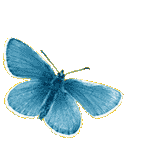Mitologia romana
I mani
Le anime dei familiari deceduti, denominati mani, erano a Roma oggetto di un culto molto sentito che, benché assumesse (al contrario della maggior parte dei culti) carattere sostanzialmente privato, venne tuttavia regolamentato ufficialmente già da una legge iscritta nelle Dodici Tavole. Nove giorni dopo la morte di un familiare si usava offrire alla sua anima del latte, del grano e, tra le altre cose, un’essenza di viole lasciate macerare nell’acqua. In loro onore si tenevano le feste denominate Parentalia, che avevano luogo nel mese di febbraio. Durante queste feste i magistrati deponevano le loro insegne per rispetto verso i defunti, e i templi venivano chiusi; la tradizione vuole che questo tipo di devozione fosse stata istituita dallo stesso Enea in onore del padre Anchise. Si tramanda anche che un solo anno a Roma si trascurò di celebrare queste feste, e che le anime dei morti tanto se ne adontarono da lasciare le tombe e circolare liberamente per la città terrorizzando chiunque incontrassero. Durante altre feste, denominate perlopiú Rosaria (o anche Violaria) si usava invece colmare le tombe di rose e viole.
Interessante è l’origine del nome dato a questi spiriti: si tratta di un aggettivo, mānis, māne, che anticamente significava “buono” e che ben presto cadde in disuso, tranne che nel suo uso sostantivato¹. I Mānes sono dunque I buoni (spiriti). Si tratta evidentemente di un uso propiziatorio: rivolgersi a queste anime con un un atteggiamento di rispettosa adulazione serviva, nell’intenzione di chi le invocava, a non provocarne l’ira o il risentimento. L’atteggiamento nei confronti di queste anime risulta in effetti, in una certa misura, ambiguo: al senso di venerazione e di rispetto si mescola un sentimento di timore e perfino di diffidenza: i morti appartengono a un mondo misterioso e incomprensibile, da trattare con estrema cautela.
Si collegano a questo tipo di sentimento anche altre credenze, come quella nelle larve e nei lemuri.
- Rimane però nel latino classico l’aggettivo di significato opposto: immānis, immāne, che tuttavia dall’originario significato di “cattivo” passa poi all’accezione di “abnormemente grande”.
22 ottobre 2014
Questo testo è proprietà intellettuale dell’autore, Ferruccio Sardu. La sua riproposizione, anche parziale, implica la citazione della fonte.